| 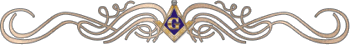
| 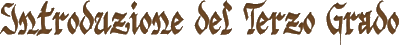 | L’oggetto della terza parte del presente lavoro è lo studio delle origini del Terzo Grado e del Sacro Arco Reale , inteso dapprima quale quarto grado e, dopo la nascita della Gran loggia Unita d’Inghilterra, come completamento del grado di Maestro.Preliminarmente, appare opportuno rapportare l’Arco Reale con l’introduzione del Terzo Grado nella Libera Muratorìa: è noto infatti, che almeno fino al 1725 soltanto due erano i gradi praticati in Loggia ; il grado di Apprendista Accettato e quello di Compagno d’Arte.I manoscritti massonici più antichi di cui abbiamo traccia (come ad es. il Graham ed il Kevan), riportano peraltro soltanto la formula del giuramento dell’Apprendista, in seguito divenuto accettato, espressione verbale dal duplice significato: accettazione del cowan - da tradursi come estraneo -, nella Fratellanza, ed accettazione, in seguito, dei primi speculativi nelle Logge un tempo composte soltanto da operativi. Ed è proprio all’iniziativa degli speculativi, - spesso provenienti dalla Royal Society e studiosi delle arti liberali ma anche dei Manifesti Rosacroce e del Corpus Hermeticum - ad opinione di chi scrive, che dobbiamo l’introduzione della leggenda hiramica, e di conseguenza il Terzo Grado. Il termine Maestro, nel manoscritto Graham era sinonimo di Compagno, o al più poteva indicare il primus inter pares della Loggia, ma non certo un libero muratore dotato di un grado di conoscenza e di segreti o parole di passo ignote agli altri fratelli. Tutto ciò cambia almeno dal 1725 in poi, ed i Compagni meritevoli sono elevati sempre più spesso nelle Logge. La conferma del definitivo affermarsi del  trigradualismo, ci è infine data dal libello Massoneria Disvelata, pubblicato nel 1730, in cui il Pritchard ne spiega contenuti e caratteristiche. trigradualismo, ci è infine data dal libello Massoneria Disvelata, pubblicato nel 1730, in cui il Pritchard ne spiega contenuti e caratteristiche. Non è un caso che la seconda edizione delle Costituzioni andersoniane, che è del 1738, è emendata in più parti proprio al fine di adeguarle all’importanza decisiva che la parola Maestro ha assunto nel Craft. L’introduzione del Grado di Maestro risale all’incirca al 1725. La ragione che portò all’individuazione di Hiram Abif come fulcro del Terzo Grado, e come la più fulgida figura di Maestro Massone, rimane tuttavia oscura. Pur presente nella fantasiosa storia dell’Istituzione elaborata da Anderson nel 1723, il ruolo che gli era attribuito non appariva certo così decisivo, limitandosi il pastore presbiteriano a narrare di lui traendo spunto dalle sue conoscenze bibliche.Sempre che vi sia - e non vi è - unanimità di vedute sull’identità stessa di Hiram, essendovi un Hiram Re di Tiro, ed un altro Hiram figlio di una vedova della tribù di Neftali, donna delle figlie di Dan e di padre Tirio .La storiografia massonica largamente prevalente , concorda però sul considerare valida la seconda ipotesi.Del resto, nelle Costituzioni del 1723, Anderson lo descrive come il “muratore più perfetto della Terra”, il “Principe degli Architetti”, la cui linea di discendenza è appunto quella della vedova di Neftali, inviato a sovrintendere alla realizzazione del Tempio di Gerusalemme dal suo omonimo Re di Tiro.Chi è dunque Hiram Abif nella storia massonica? Colui che viene definito, negli antichi manoscritti giunti fino ai nostri giorni, Aynom, Amon, Anon, Apleo..nomi sostitutivi che sembrano indicare, molto spesso, soltanto a man, un uomo, al quale le Costituzioni della Craft operativa fanno riferimento, ma che non coincide con l’Hiram di cui si narra nelle Scritture.L’irrompere del trigradualismo, comporta anche una modifica rilevante del primo e del secondo grado: i cinque punti della Fratellanza, componente decisiva del secondo grado, divengono parte del terzo, il primo grado viene scomposto in due parti , grazie all’apporto di Desaguliers, che ha un ruolo decisivo nell’elaborare i “nuovi” contenuti del secondo grado, vale a dire i misteri occulti della natura e della scienza, e lo studio delle sette arti liberali.Che l’influenza della Fratellanza Interna sia stata decisiva, nel dare al terzo Grado ed alla leggenda di Hiram un significato altro, non sembra poter essere messo in discussione.I significati stessi della cerimonia di elevazione al grado di Maestro, sono irriducibili alla natura operativa originaria della vecchia Craft, se si eccettuano i Cinque Punti della Fratellanza, presenti in quasi tutti gli antichi Manoscritti, parte centrale del vecchio secondo grado, poi integrati nel terzo. Su di essi, non si è in possesso, purtroppo, di alcun riscontro. Non si sa nulla sul quando né sul come della loro formazione, al pari delle parole del Terzo Grado .Rappresentano, tuttavia, un elemento di fortissima suggestione per chi è soggetto passivo dello psicodramma rituale, e danno plastica dimostrazione del significato più profondo del vincolo virtuoso che lega i fratelli per la vita. Prima di cercare di delineare più precisamente la figura di Hiram, è bene riprodurre il contenuto di un Manoscritto. Di seguito, la traduzione del Manoscritto Graham: MANOSCRITTO GRAHAM (1726) TRADUZIONE [.....] Abbiamo la Tradizione, ma anche riferimenti nella Scrittura, che Sem Cam e Japhet si recarono sulla tomba di Noè, loro padre, per tentare di scoprire qualche cosa che li aiutasse a trovare il potente segreto che deteneva questo famoso patriarca. Qui, spero che tutti ammettano che le cose necessarie al nuovo mondo si trovavano nell'arca con Noè. Questi tre uomini convennero che se non avessero trovato il vero segreto, la prima cosa che avrebbero scoperto sarebbe stata in ogni caso considerata come il loro segreto. Non avevano dubbi, credevano molto fermamente che Dio poteva e avrebbe potuto anche rivelare la propria volontà, per la loro fede la loro preghiera e obbedienza; così quanto scoprirono si dimostrò, per loro, tanto utile come se avessero ricevuto il segreto fin dal principio, da Dio stesso, dalla sorgente stessa. Arrivarono alla tomba e non trovarono niente, se non il cadavere quasi interamente putrefatto. Afferrarono un dito che si staccò e così via di giuntura in giuntura fino al polso ed al gomito. Allora, sollevarono il corpo e lo sostennero mettendosi con lui piede contro piede, ginocchio contro ginocchio, petto contro petto, guancia contro guancia e mano nella schiena, ed esclamarono: " Aiutaci, Padre!" Come dire; " O Padre del cielo aiutaci, perché il nostro padre terrestre non lo può". Riposero poi il cadavere, non sapendo cosa fare. Uno di loro disse allora: "C'è ancora del midollo in questo osso ", ed il secondo disse " ma è un osso secco "; ed il terzo disse "puzza ". Si accordarono in quella occasione per dare a questo osso un nome che è ancor oggi conosciuto in Massoneria. [.....] Da Graham Maestro Venerabile della Loggia Enquam Ebo [16] La parte evidenziata in corsivo, ha per oggetto la tradizione noachita. Di più, è sufficiente comparare il ruolo svolto dai figli di Noè, ed il Terzo Grado così come viene descritto nel testo antimassonico di Prichard, Massoneria Disvelata, del 1730, per rendersi conto della fortissima somiglianza tra i due testi. La leggenda hiramica sembra dunque essere ricalcata su un episodio avvenuto in seguito alla morte di Noè, ed agli atti posti in essere dai suoi figli: nel primo caso, con la cieca violenza, nel secondo, incuranti della morte, il filo conduttore è la ricerca del potere, il desiderio dell’uomo di superare il limite segnato dall’Altissimo. Altro elemento comune, è quello necromantico: si cerca di ottenere un segreto da un corpo morto , che è in putrefazione. Il tentativo, che ripugna ad ogni credente, ma soprattutto ad ogni essere umano dotato di morale, sembra finanche ricalcare elementi di negromanzia oscura, diremmo controiniziatica. Non a caso i misteri genuini non sono ottenuti, né dai figli di Noè, né dagli assassini di Hiram, e vengono cambiati, necessariamente, con misteri sostitutivi. Hiram, dunque, è simbolo fra i simboli, e nel passato vi è chi ha individuato in lui le fattezze dello Stuart pretendente al trono d’Inghilterra, ingiustamente privato dei suoi diritti, o come altri autori tanto un elemento psicologico, che richiama all’esperienza primitiva, primordiale dell’uomo storico che è dentro ciascuno di noi, quanto un elemento mitologico, raffigurando in lui Osiride, che rinasce a nuova vita.Queste riflessioni mi convincono, ma solo in parte. Senz’altro il crogiolo filosofico e spirituale che ha portato alla definitiva affermazione di questo dramma rituale, poggia anche su queste basi, ma il richiamo più forte, che mi sembra di individuare, è nell’ambiente rosacrociano , che a partire da Ashmole ha popolato le Logge negli anni precedenti il 1717.In esso, ed in particolare ne Le Nozze Chimiche, ritrovo numerosi elementi, ma soprattutto i medesimi sentimenti. Del resto, come ci viene ricordato da un fratello autorevole: “morire, è essere iniziato ”. | 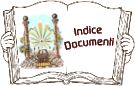
|
|
|
|
|