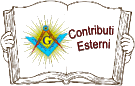Introduzione
La conoscenza deriva in noi da un'elaborazione operata tramite l'analisi e la sintesi in seno agli stati di coscienza. Si rivela come una cosa che non è puramente passiva, ma alla quale partecipa un agente attivo che ci è proprio. Il lavoro di ridistribuzione operata in seno alla coscienza prende per punti di appoggio alcune nozioni fondamentali, tipo di stampi, di campioni, di modelli, senza quali non potrebbe stabilirsi, in seno al turbinio caotico delle impressioni, l'ordine e la precisione necessaria ad ogni conoscenza appena appena chiara.
Queste nozioni: sostanza, incidente, causa effetto, relazione qualità, essenza, quantità, tempo spazio, forza, resistenza, intensità azione, passione piacere, dolore ecc., da dove vengono ed a quale realtà possono rispondere? È qui il problema fondamentale, il perno di tutti i sistemi filosofici, che si è presentato sotto diverse forme ma che non ha trovato mai soluzione completata. Secondo alcuni, queste nozioni generali sono il risultato unico delle nostre esperienze e mantengono tutto il loro valore dalla loro utilità, sono, in altre parole, dei modi arbitrari di raggruppare le cose. Secondo altri, sono inerenti alla costituzione del nostro spirito: sono le forme del pensiero che imponiamo ai dati di un mondo esterno le cui le forme ci rimangono impenetrabili. Altri ancora, infine, considerano queste nozioni come le leggi obiettive dell'universo, leggi che sono anche queste del nostro spirito che è lui stesso parte integrante dell'universo.
E quando il contatto col mondo esterno ci fa entrare in vibrazione, scopriamo al tempo stesso la nostra propria modalità e quella degli oggetti che l'hanno armonicamente determinato, e ancora che il ritmo dello shock ci svela la doppia faccia dell'io e del non io. Questa ultima ipotesi ci sembra più attendibile, contenendo in sé la sintesi delle altre due e aggiungendovi qualche cosa di più.
| |